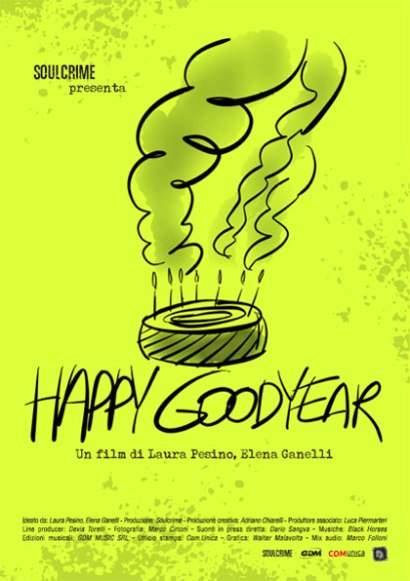Non entravo all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina da tempo, ieri ci sono andato da paziente, per una visita programmata . Nei poliambulatori al di sotto di malattie infettive eravamo io e una signora: minuta, occhi chiari, tanta voglia di raccontare di sé, dei suoi malanni e dei disagi che affronta. La chiamerò Cristina e nei giorni delle polemiche sulle liste d’attesa o della prosopopea sugli “Stati generali della salute” mi va di raccontare la sua storia.
Perché è una di quelle – tante, tantissime – che i giornali hanno “dimenticato” di seguire, presi come sono dai diktat di chi comanda che preferisce le veline alla vita reale. Non mi stupisce, è un mondo nel quale ho vissuto a lungo e so come funzionano certe cose. Però le storie come quella di Cristina “fanno” ancora notizia e qualcuno dovrebbe continuare a preoccuparsene, per rispetto della professione che facciamo.
Ci provo io, sommessamente. La signora in questione grazie alle prevenzione ha scoperto anni fa un tumore al seno, è stata operata e segue regolarmente lo screening. Nel frattempo un altro tumore è comparso, stavolta al colon, quasi per caso come mi ha raccontato lei, facendo accertamenti per un’altra patologia (“non mi faccio mancare niente”). Anche in questo caso, è stata operata e le sono stati prescritti esami diagnostici di controllo. Nello specifico la colonscopia che deve eseguire con calma, entro un anno. “Però non c’è posto, non me la prenotano, così sono costretta a pagarla”. Sì, avete capito bene. Una donna operata di tumore, con il famigerato codice 048, costretta a pagare la colonscopia di controllo.
Mentre i direttori generali e sanitari delle Asl ripetono come un mantra che è necessaria la “presa in carico” dei pazienti, quelli fragili in particolare o con comorbidità, Cristina deve trovare per conto proprio un centro dove fare la colonscopia e pagarsela. Non è questione di Rocca o di Zingaretti che l’ha preceduto, attenzione, ma di civiltà. Quella che la politica e i supermanager che nomina, hanno dimenticato. Una normale “presa in carico” dovrebbe prevedere che la struttura alla quale la donna è affidata, le programmi e prenoti direttamente l’esame. Invece no, una cittadina malata di tumore deve fare il giro delle sette chiese e pagarsi pure la prestazione.
Direte “ma credi a quello che ti ha raccontato”? Sì, ma ho pure verificato ed è la stessa regione nel suo “Monitoraggio sui tempi di attesa” (aggiornato al 27 agosto, mentre scrivo è il 19 novembre 2025) a riconoscere che l’indice per la colonscopia è pari a 55. Il che significa che la prima prestazione utile entro l’anno, Cristina la può anche ottenere ma non a Latina (indice 49,7, quindi attesa ancora più lunga rispetto alla Regione).

E se è una donna sola che non guida più come un tempo? Cerca una soluzione vicino casa e paga. Per dovere di cronaca è giusto dire che la stessa prestazione, tenendo conto dell’offerta in tutto il Lazio ha un indice di 80 se urgente (sono quelle che possono prenotare direttamente i medici e vanno eseguite nell’arco di 72 ore), scende a 55,4 se breve (da fare entro 10 giorni), a 52,4 se differibile (entro 60 giorni) e risale a 59,3 se programmata ovvero da eseguire entro 120 giorni.
E questa storia della colonscopia apre un’altra pagina. La collega Linda Di Benedetto ha scritto sul Fatto Quotidiano che la Regione Lazio fornirebbe dati alterati rispetto alle liste d’attesa. Il presidente Rocca si è difeso, sostenendo di essere nel giusto.
In realtà basta recarsi a uno sportello Cup o telefonare al Centro unico di prenotazione per scoprire che le cose stanno in questo modo innegabile e beffardo: il paziente di Anzio ha una prescrizione con priorità B. Chiama e in un ambulatorio vicino casa non c’è posto, può spostarsi e chiede per altri centri nel raggio di una trentina di chilometri (Aprilia, Latina) o magari Roma dove può andare in treno ma entro 10 giorni non c’è posto. Anzi sì, a Cassino o Viterbo. Risultato? Il paziente dice “no grazie”, il sistema regionale di prenotazioni dice “ok, ma io entro 10 giorni te l’avevo garantita e sei tu che hai rifiutato”. Con la conseguenza che il paziente si rivolge al privato e la Regione dice di rispettare i tempi.
Qualcuno lo spieghi a Cristina e a quanti, come lei, si sentono presi in giro quando gli si racconta che sulle liste d’attesa è tutto a posto. Ripeto, non ne faccio e non ne ho mai fatto una questione di chi guida la Regione ma di onestà intellettuale.
Infine, per la medesima onestà, è giusto dire che le liste sono solo uno dei problemi e che se domani mattina apriamo un servizio, tra una settimana le attese si creano. Questo non vale, però, per le situazioni come quella di Cristina e di tanti altri. Non può e non deve valere.